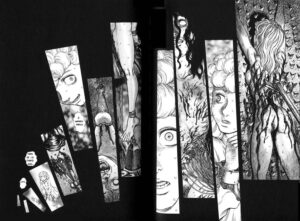
Introduzione di Insectionals
Quando ci approcciamo al tema della tortura non possiamo evitare di riallacciarci a tutte quelle considerazioni maturate negli ambienti illuministici. In Italia abbiamo avuto una lunga tradizione di denuncia politica sulla pratica della tortura e, di conseguenza, anche verso quelle istituzioni che la impiegavano apertamente come strumento di “giustizia”.
Pensiamo, ad esempio, al filosofo Pietro Verri e alle sue “Osservazioni sulla tortura”: questo scritto era stato redatto attraverso le analisi delle documentazioni processuali e ispirò, qualche secolo dopo, Manzoni con la sua “Storia della Colonna Infame”.
Ma se per lo scrittore de “I Promessi Sposi” la questione andava analizzata da un punto di vista etico, senza trascurare la propria prospettiva cattolica legata al male (teodicea) che non derivava dal cattivo uso degli “strumenti di giustizia” ma dallo scellerato impiego del raziocinio e del libero arbitrio degli uomini (intesi come singoli e non come collettivo o gruppo), lo spazio politico veniva completamente eclissato in virtù di un certo punto di vista che manteneva de facto ed intatto la forza e il monopolio della violenza dello Stato.
Verri, al contrario, non risparmiava la propria critica alle istituzioni, scrivendo in un periodo storico che poteva compromettere la sua stessa libertà. Come egli dichiarava nella sua opera citata: “Cerco di camminare placidamente alla verità” (“Osservazioni sulla tortura”, pag. 416)
Il Senato di Milano, infatti, era favorevole a mantenere la tortura come parte integrante dei processi, motivo per cui Verri era stato persuaso, senza successo, ad astenersi dalla pubblicazione dell’opera ed evitare, in tal modo, le possibili ritorsioni come “agitatore politico” – in quanto metteva in discussione lo status quo ed il sistema istituzionale del suo tempo.
Contemporaneo di Verri era stato il giurista Vincenzo Malerba, il quale affermava che:
“La tortura si pratica non per punizione del delitto, di cui non si sa l’autore, ma per ritrarre dalla bocca dell’accusato quella verità, che per la debolezza delle ragioni, e l’inconstanza, astuzia, e falsità di testimoni giace spesse volte ascosa nelle tenebre dell’incertezza […]. Sarà talvolta un innocente colui, quale fu sottoposto alla tortura. Che perciò? I dolori, che ha sofferto, dovranno allora riguardarsi, come ingiurie, non già del Magistrato, ma della fortuna avversa, alla quale tutti noi siamo ugualmente soggetti […]. Ma si concede agli avversari, che un innocente torturato ceda al dolore, e si dichiari reo, nel caso eziandio, in cui la tortura fosse ordinata dal Giudice con tutte quelle condizioni, che si richieggono. Qual pro per essi? Alla rarità di questo esempio oppongo la pubblica utilità risultante dalla legge della tortura. Dire di più, che l’inconveniente di soggettare alla pena un innocente, che nel tormento si confessa reo, non dee attribuirsi all’ingiustizia, e barbarie della tortura, ma ad una colpevole debolezza, ed alla mancanza d’uno spirito virtuoso. La pazienza è un dovere, e dovere indispensabile. L’innocente condannato al tormento deve accettare con rassegnazione, e soffrire con tolleranza tutti i patimenti, come un servo, il qual piega le spalle sotto la sferza, che lo percuote, facendosi de’ suoi propri mali un mezzo per un bene.” (Malerba, “Ragionamenti supra la tortura”)
Oltre al problema etico, Verri poneva la questione dei tormenti fisici “legali” anche in un ambito di isteria di massa – la quale era indotta dalle logiche persecutorie su cui si basava l’impianto della tortura (volta a “stanare” il colpevole e a trovarlo senza compromessi, costi quel che costi). Il filosofo milanese aveva preso come esempio storico il clima di sospetto creatosi durante la pestilenza che colpì, in particolare, Milano – e incentivato dalle istituzioni . Come scrisse nella sezione “Se la tortura sia un mezzo lecito per iscoprire la verità”:
“Debbesi sempre ridurre la questione a questo punto: o il delitto è certo, ovvero è solamente probabile. Se è certo il delitto, i tormenti sono inutili, e la tortura è superfluamente data quand’anche fosse un mezzo per rintracciare la verità, giacchè presso di noi un reo convinto si condanna benchè negativo. La tortura, dunque, in questo caso sarebbe ingiusta, perchè non è giusta cosa il fare un male e un male gravissimo ad un uomo superfluamente. Se il delitto poi è solamente probabile, qualunque sia il vocabolo col quale i Dottori distinguano il grado di probabilità difficile assai a misurarsi, egli è evidente che sarà possibile che il probabilmente reo in fatti sia innocente. […] Se è cosa ingiusta che un fratello accusi criminalmente l’altro, a più forte ragione sarà cosa ingiusta e contraria alla voce della natura che un uomo diventi accusatore di se stesso e le due persone dell’accusatore e dell’accusato si confondano. La natura ha inserito nel cuore di ciascuno la legge primitiva della difesa di se medesimo e l’offendere se stesso e l’accusare se stesso criminalmente egli è o un eroismo, se è fatto spontaneamente in alcuni casi, ovvero una tirannia ingiustissima, se per forza di spasimi si voglia costringervi un uomo” (Ibidem, pagg. 470-471).
È da segnalare che Verri aveva scritto tutto questo in un momento storico dove la tortura era effettivamente in vigore (nonostante le abolizioni in diverse parti d’Europa). Dello stesso avviso era stato il suo compagno di pensiero, nonché coetaneo e concittadino, Cesare Beccaria che, nel “Dei delitti e delle pene,” affermava:
“Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta di complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe essere reo, ma dei quali non è accusato.” (Capitolo XVI, “Della Tortura”)
Tuttavia, i ragionamenti di stampo illuminista difficilmente si sono occupati di ricostruire l’impiego della tortura nel corso della storia e, in particolare, di imputarla all’essenza stessa dello Stato.
Come scriveva Alfredo Maria Bonanno ne “L’inquisizione. La tortura in nome di Dio”:
“la tortura è pratica corrente di qualsiasi istituzione giudiziaria e poliziesca, dall’antichità ai giorni nostri” (pag. 166) atta a rendere inumano, razionalmente e scientificamente parlando, l’uomo e “conferendogli l’autorizzazione ad [essere tale], in nome di progetti e ideali che si chiarificheranno in futuro, in nome della storia, in nome della fraternità e così via.”
Condannare la tortura, però, non implica una legittimazione dello “Stato di diritto” -ovvero: abolita la tortura, le istituzioni risulteranno comunque innocenti ed estranee. Il diritto di uno Stato si fonda su quel “bellum omnia contra omnes” caro ad Hobbes o, per dirlo in modo più semplice, sulla violenza.
“Se c’è qualcosa che desta meraviglia”, scrive Bonanno nell’opera citata, “è il profondo interesse che tutti hanno a non riconoscere la vera sede della disumanità. Non nell’uomo, in generale, per cui diverrebbe un’astratta ipoteca sul futuro di tutti, ma nell’istituzione regolarizzatrice, che appunto razionalizzando l’uomo lo rende potenziale strumento di morte nelle forme più atroci.”
Lo Stato, quindi, incarna la violenza e cercherà sempre di mantenere e perpetuare non solo lo status quo ma anche il monopolio esclusivo della brutalità. Ed è a partire da queste considerazioni che si presenta lo scritto di Barbedette: attraverso un excursus storico, l’anarchico francese fa una disanima provocatrice e dura sulla tortura su come veniva (e venga ancor oggi, visto i numerosi casi Cucchi o violenze all’interno delle carceri italiane) usata all’interno delle infrastrutture di controllo e repressione.
===================================================================
Tratto dall’Encyclopédie anarchiste, Tomo 4, pagg. 2257-2258, voce “Question (Torture)” scritta da Lucien Barbedette
È dalla legislazione romana che i nostri giudici hanno preso in prestito l’uso della tortura, o dell’interrogatorio se preferite: si sosteneva che lo scopo di questo mezzo procedurale servisse a scoprire la verità, strappando all’accusato una confessione del suo crimine o delle rivelazioni sui suoi complici.
Conosciamo i raffinamenti di crudeltà a cui scendono gli orientali in generale, e i cinesi in particolare, quando si tratta di torturare.1 Ad Atene la tortura era riservata agli schiavi; a Roma la testimonianza degli schiavi era valida solo se ottenuta tra i tormenti. L’elenco dei vari metodi di tortura sarebbe immenso; dopo essere stati usati contro i primi cristiani, i peggiori supplizi venivano usati contro gli eretici. In Francia, l’interrogatorio sostituì le prove giudiziarie o ordalie comunemente usate nel Medioevo.
Poiché Dio, si diceva, non poteva abbandonare l’innocente, l’accusato doveva dimostrare, attraverso l’ordalia, di avere per sé l’amicizia del cielo. Alcune di queste prove sono rimaste famose.
La prova dell’acqua prevedeva l’uso di acqua bollente o di acqua fredda. Nel primo caso, il braccio doveva essere immerso in una vasca di acqua bollente, ad una profondità maggiore o minore a seconda della natura dell’accusa, per estrarre una pietra o un anello benedetto dal sacerdote. Il braccio veniva poi avvolto in una busta e sigillato dal giudice. Se dopo tre giorni il prigioniero non presentava ustioni, veniva dichiarato innocente. Nella prova dell’acqua fredda, l’accusato veniva gettato in un lago, in un fiume o in una vasca, dopo aver legato la mano sinistra con il piede destro e la mano destra con il piede sinistro. Se affondava, veniva dichiarato innocente; se galleggiava, veniva dichiarato colpevole, perché l’acqua, benedetta in precedenza, lo respingeva a causa dei suoi crimini. Tuttavia, in alcune località si accettava la regola opposta: il colpevole affondava e l’innocente galleggiava.
La prova del ferro infuocato veniva eseguita in modi diversi. A volte si doveva camminare a piedi nudi sui vomeri arrossati dal fuoco; altre, invece, era una barra di ferro rovente che si doveva afferrare e sollevare più volte; in altri casi, si dovevano infilare la mano e il braccio in un guanto di ferro. Dopo tre giorni, il giudice dichiarava il prigioniero non colpevole se non vi fossero state tracce di bruciature.
Per la prova della croce, l’accusatore e l’accusato stavano in piedi con le braccia incrociate; chi rimaneva in questa posizione scomoda più a lungo vinceva la causa.
Nel Duello di Dio, le due parti contrapposte lottavano l’una contro l’altra; a volte anche i testimoni e il giudice dovevano rispondere alle provocazioni.
Gli avvocati o i paladini potevano prendere il posto delle parti; questa era la regola quando erano coinvolte donne o chierici. I poveri si portavano i bastoni, mentre i nobili indossavano un’armatura completa con scudo, lancia e spada. Permettendo la vittoria ad uno dei due uomini, si assicurava che Dio ne garantisse l’innocenza. Prima di questi processi era consuetudine celebrare una messa, il cui testo è stato ritrovato negli antichi messali. Tuttavia, queste pratiche erano così assurde e portavano ad ingiustizie così evidenti che alla fine furono vietate. Ma scomparvero molto lentamente: la prova dell’acqua fredda era ancora in uso all’inizio del XVII secolo; e il duello, ancora oggi usato privatamente, è un diretto discendente dell’antico Duello di Dio.
Ahimè! Le inchieste penali si basarono sugli interrogatori quando le ordalie passarono di moda. Con il pretesto di migliorare la legge, essa divenne più atroce: le prove giudiziarie erano inique, ma non risolvevano il punto del contendere; non erano così gli interrogatori – i quali a volte diventavano una tortura interminabile.
Stabilita, si affermava, per difendere l’innocenza, [la tortura, invece,] serviva per perderla.
Montaigne osservava:
“È un’invenzione pericolosa quella delle torture, e sembra che sia piuttosto una prova di resistenza che di verità. E colui che le può sopportare nasconde la verità come colui che non le può sopportare. Di fatto, perché il dolore dovrà farmi confessare ciò che è, e non mi forzerà piuttosto a dire ciò che non è? E, al contrario, se colui che non ha commesso quello di cui lo si accusa è abbastanza forte per sopportare quelle torture, perché non lo sarà colui che lo ha commesso, essendogli promesso un così bel guiderdone come la vita? Penso che il fondamento di questa invenzione poggi sulla considerazione della forza della coscienza. Infatti nel colpevole sembra che essa aiuti la tortura per fargli confessare la sua colpa, e che lo indebolisca; e d’altra parte, che fortifichi l’innocente contro la tortura. A dire il vero, è un sistema pieno di incertezza e di pericolo. Che cosa non si direbbe, che cosa non si farebbe per sfuggire a così gravi dolori? Etiam innocentes cogit mentiri dolor. Da ciò deriva che colui che il giudice ha torturato per non farlo morire innocente, lo faccia morire e innocente e torturato.”
Da parte sua, La Bruyère dirà:
“È un’invenzione sicura per salvare un robusto colpevole.”2
E Beccaria sottolineerà che una confessione estorta con la tortura manca di valore probatorio:
“Dunque l’impressione del dolore può crescere a segno, che, occupandola tutta, non lasci altra libertà al torturato, che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena.”
Malgrado le proteste di tutti gli spiriti generosi, la questione rimase aperta fino alla fine del XVIII secolo. L’ordinanza penale emanata da Luigi XIV nel 1670 era draconiana. Obbligava gli imputati a “rispondere di propria bocca, senza l’assistenza di un avvocato”. A condizione che “il crimine non sia capitale”, i giudici “possono permettere all’accusato di conferire con chi vuole”, ma solo dopo l’interrogatorio. Per evitare che i testimoni dell’accusa ritrattino le loro dichiarazioni, “coloro che ritrattano saranno perseguiti e puniti come falsi testimoni”.
Si invitava il giudice a non portare l’interrogatorio verso la morte, limitandosi, su questo argomento, nel ricordare i vecchi provvedimenti. Il modo in cui applicarlo era lasciato all’arbitrarietà dei magistrati – tanto che lo spregevole e crudele Pussort aveva ritenuto che una descrizione della tortura sarebbe stata “indecente”. Il provvedimento era molto ambiguo verso coloro che non potevano essere sottoposti all’interrogatorio. Quindi, in pratica, i tribunali non avevano altra regola che la loro fantasia. Si distingueva tra l’interrogatorio preparatorio, volto ad ottenere dall’imputato una confessione del reato, e l’interrogatorio preliminare, rivolto al condannato per ottenere informazioni sui suoi complici. Il primo era disposto quando non c’erano riserve sulle prove; e allora l’imputato che non confessava veniva assolto. Invece, quando c’era una riserva, l’assenza della confessione lo strappava alla pena di morte solo se mancavano testimonianze convincenti. Un chirurgo o un barbiere, presente alle sessioni di tortura, indicava i limiti che non potevano essere superati senza togliere la vita all’imputato.
A metà del XVIII secolo si ricorreva a terribili tormenti. Per aver sfiorato il fianco di Luigi XV, Damiens fu sottoposto a lunghe torture preliminari; poi, [durante l’esecuzione per squartamento], gli venne bruciata la mano destra, strappata la carne con le tenaglie, versato piombo fuso nelle ferite e, infine, fatto a pezzi. È vero che, nello stesso periodo, il furto di un paio di lenzuola da parte di un servo era punito con l’impiccagione, e che un reato di caccia valeva al colpevole una condanna a vita nelle galere. La gogna, la ruota e le mutilazioni barbariche non erano scomparse.
Nel supplizio della ruota, venivano spezzate le braccia, le gambe e le costole e veniva legato a due pezzi di legno disposti a forma di croce di Sant’Andrea; poi veniva posto, con le braccia e le gambe dietro la schiena, su una piccola ruota sostenuta da un palo. L’interrogatorio del fuoco, praticato anche da alcuni famosi briganti, consisteva nel sottoporre le piante dei piedi ad un fuoco sempre più intenso. Nell’interrogatorio con il ferro, i pollici venivano schiacciati con una macchina. A partire dal XVI secolo, tuttavia, lo stiramento, l’acqua e i brodequins (supplizio dei ceppi, ndt) divennero le forme di tortura più comuni. Nella prima fase dello stiramento, un peso di 180 libbre veniva attaccato al piede destro dell’accusato, che veniva poi sospeso con una corda; nella seconda fase, mani e piedi venivano tirati con corde attaccate da un lato a un anello sul pavimento e, dall’altro, ad anelli posti sul muro – ad un’altezza di tre piedi -; per dislocare gli arti, venivano fatti passare sotto di lui cavalletti di altezza crescente. Un corno, che fungeva da imbuto, veniva inserito nella bocca del soggetto quando avveniva l’interrogatorio dell’acqua. Se non confessava, ci si fermava soltanto dopo che era stato costretto ad ingerire circa sei litri di liquido nell’interrogatorio ordinario – dodici in quello straordinario. Per la tortura dei brodequins, le gambe venivano bloccate da due assi di quercia e legati con delle corde; successivamente, l’aguzzino, a colpi di martello, introduceva tra le aste centrali dei cunei di ferro o legno – il cui numero, in alcuni casi, superava le otto unità. Le gambe diventavano informi e il midollo fuoriusciva dalle ossa rotte. In fatto di torture, i nostri antenati non avevano molto da invidiare ai cinesi!
I filosofi del XVIII secolo protestarono ardentemente contro queste pratiche disumane. Montesquieu denunciò la barbarie delle nostre leggi penali; la traduzione francese del “Traité des délits et des peines” dell’italiano Beccaria ebbe un enorme successo; Voltaire denunciò la procedura segreta, l’ingiustizia dei tribunali e le pene atroci. Nel 1780 il re abolì l’interrogatorio preparatorio, ma quello preliminare rimase fino alla Rivoluzione.
Ahimè! Nel XIX secolo, la tortura fu sostituita dalla segretezza. Tenuto in assoluto isolamento, l’accusato poteva vedere solo il suo carceriere; gli era proibita ogni distrazione; non gli era permesso di leggere o scrivere. E questo calvario, a volte, durava mesi e mesi!
Sappiamo che oggi gli agenti di polizia e i commissari continuano a sottoporre i detenuti ad orribili vessazioni. Spogliati, picchiati con manganelli o sottoposti a torture più raffinate, gli sfortunati prigionieri che cadono nelle mani degli agenti non hanno nemmeno il diritto di lamentarsi. Giudici e autorità chiudono volentieri un occhio, per poi proclamare, senza battere ciglio, che tali pratiche non esistono. E se un prigioniero muore per mano della polizia, la sua famiglia non può dirlo senza esporsi a condanne rovinose e a sanzioni ancora peggiori. È per far soffrire coloro che tengono nelle loro grinfie che molte guardie carcerarie si impegnano [nelle torture]. I vecchi abusi stanno cambiando, ma persistono grazie alla complicità dei capi.
—Su Lucien Barbedette
Nato il 13 Agosto 1890 a Levaré (Mayenne), a 23 anni Barbedette rinunciò alla vocazione da missionario cattolico e si laureò in filosofia e scienze naturali. Nel 1919 venne nominato professore al Collège de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), dove insegnò filosofia e storia. Antoine Perrier, che lo conobbe nel 1923-1925, lo descrisse così: “Era piccolo di statura, reso ancora più piccolo da un semplice mantello che arrivava quasi a terra, e da una bombetta posta su una testa illuminata da occhi piccoli e vivaci, dietro spessi occhiali, allungati da una lunga barba fulva”. Amichevole e mite, Barbedette attirò molte simpatie grazie alla sua preparazione culturale e al rapporto amichevole e aperto con i suoi studenti.
Nel 1925 fu membro insieme ad altri anarchici – tra cui L. Rimbault e V. Spielman – del comitato direttivo de “Les Compagnons de la pensée”, i cui presidenti erano Han Ryner e J.H. Rosny.
All’inizio degli anni Trenta, Barbedette divenne membro onorario dell’ “Union des Intellectuels Pacifistes” (UIP), il cui presidente era Gérard de Lacaze-Duthiers, la vicepresidente Lucie Caradek e il segretario Louis Fillet. L’UIP pubblicava il giornale “La Clameur” (almeno 14 numeri tra il Novembre 1932 e l’Aprile 1936), diretto da René de Sanzy.
Desideroso di far conoscere le sue idee ad un pubblico più vasto rispetto a quello che lo ascoltava negli angusti confini della sua aula, Barbedette pubblicò a proprie spese degli opuscoli filosofici con le Editions de la Fraternité Universitaire (Limoges, 1934-1940) e scrisse diversi articoli per i giornali anarchici francesi dell’epoca quali, per esempio, “L’Action libre” (Parigi, 1931-1935), “Ce qu’il faut dire” (Bruxelles, 1934-1936), “L’En-dehors” (1922-1939), “Le Réfractaire” (Parigi, 1927-1932) e “La Voix libertaire” (Limoges, 1929-1939).
Inoltre fu un collaboratore attivo sulle questioni filosofiche e storiche per l’Encyclopédie anarchiste di Sébastien Faure.
Barbedette, la cui salute “bisognava di cure, non si curò. Da diversi anni aveva un cuore debole, che si rifletteva nel suo lavoro di insegnante – con una ridotta vitalità, stanchezza…” (testimonianza di A. Perrier). Morì d’infarto l’8 Febbraio 1942 a Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône).
–Sull’Encyclopedie Anarchiste
Proposta e lanciata da Sebastien Faure nel 1925, il progetto doveva essere suddiviso in cinque parti:
-un dizionario anarchico
-la storia del pensiero e dell’azione anarchica
-le biografie dei militanti e dei pensatori
-le biografie degli individualità che hanno contributo con le loro opere all’emancipazione umana
-un catalogo dei libri e delle riviste anarchiche
Faure si avvalse della collaborazione di centinaia di anarchici e anarchiche tra gli anni ‘20 e ‘30 per la stesura della Prima Parte, ovvero il dizionario anarchico – diviso in 4 tomi nell’originale francese, pubblicato nel 1934 e contenente, complessivamente, 2893 pagine.
A causa della situazione internazionale, il progetto non continuò e rimase pubblicata soltanto la parte inerente al dizionario anarchico.
Per quanto riguarda la traduzione in italiano, se ne cominciò a parlare nel numero 37 de “L’Adunata dei Refrattari”, 13 Settembre 1947: nella lettera “Una proposta” (pag. 6), l’anarchico Joe Piacentino propose ai compagni italiani di tradurre in italiano l’Encyclopedie Anarchiste in quanto “contiene un’esposizione accurata di tutte le interpretazioni e di tutte le tendenze dell’anarchismo” e utile, quindi, a rendere familiari le idee anarchiche ai neofiti.
Un paio di mesi dopo, nel Dicembre del 1947, “Volontà. Rivista mensile del movimento anarchico di lingua italiana” pubblicò il comunicato “Ai compagni d’Italia” del Gruppo Libertario di San Francisco, California, dove questi si proposero di “agevolare la pubblicazione di una Enciclopedia Anarchica, con lo scopo di far conoscere agl’ignari, studiosi o meno, ai lavoratori onesti del braccio e del cervello questa nostra dottrina che s’affaccia, oggi come non mai, unica logica ed onesta soluzione […]”
Nel successivo numero, Gennaio 1948, la redazione di “Volontà”, nell’articolo “Enciclopedia Anarchica”, si dimostrò soddisfatta dell’interesse critico e costruttivo dei compagni di lingua italiana e non. Ciononostante si vennero a creare, nell’immediato, delle difficoltà di reperimento di fondi economici e, soprattutto, dei contenuti da inserire o meno in questa traduzione in italiano – come spiegato su “Volontà”, n. 11 del 15 Maggio 1950. Tra il 1959 e il 1967 l’anarchico livornese Amedeo Cesare Vannucci fece tradurre e pubblicare soltanto 18 fascicoli (lettere A-C) che corrispondevano a metà del Primo Tomo originale del Dizionario Anarchico dell’Enciclopedia Anarchica. I motivi questa scelta erano legati all’aumento delle spese di stampa e spedizione postale (“tenendo presente che, i merendoni del centro-sinistra, non contenti di aver fatto un buon aumento sulle tariffe postali nel mese di Gennaio del 1967, nel mese di Luglio dello stesso anno, hanno voluto farci un altro ritocchino. Vale a dire: che se prima occorrevano 30 lire per spedire un Fascicolo, ora ne occorrono 50” estratto dal Bollettino dell’Enciclopedia Anarchica, fascicolo 17-18) e alla mancanza di traduttori dal francese all’italiano.
Fonti consultate
-Dictionnaire des anarchistes, «Le Maitron », voce “BARBEDETTE Lucien, Émile, François”
-“L’Adunata dei Refrattari”
-“Volontà. Rivista mensile del movimento anarchico di lingua italiana”
-Bollettino dell’Enciclopedia Anarchica, fascicoli 10-11 e 17-18
Note del Blog
1L’autore cita due volte le “finezze” delle torture cinesi in questo scritto. Ma queste citazioni sono più una provocazione dell’autore nel presentare le torture come atti inumani piuttosto che fare della mera e triviale sinofobia – la quale imperversava nel mondo culturale europeo dai tempi delle due guerre dell’Oppio (1839-1842; 1856-1860) e acutizzatasi dopo la rivolta dei Boxer (1899-1901)
2Parte di questa frase verrà ripresa da Cesare Beccaria nell’opera “Dei Delitti e delle Pene”, capitolo XII “La Tortura”.